NICOLA DE ROGATIS
UNO STABIESE ALLA BATTAGLIA DI BENEVENTO
Il 26 febbraio 1266, presso Benevento, ebbe luogo la decisiva battaglia tra Svevi ed Angioini per la conquista del Regno di Napoli.
Re Manfredi, "publicus hostis, victus apud Sanctum Germanum, a Capua quoque, ubi se iactabat velle resistere, confusus abcessit. Accepi quod ... profugus per Terram Laboris se transtulit Beneventum",[1] ove intendeva resistere.
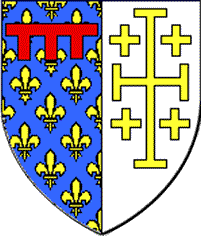

Sul campo di battaglia gli Svevi schieravano in prima linea i Tedeschi, comandati da Giordano d'Anglona; in seconda Tedeschi, Lombardi e Toscani, agli ordini di Galvano e Bartolomeo Lancia. In terza linea, di riserva, con Meridionali e Saraceni lo stesso re Manfredi.
Molto più dinamico lo schieramento angioino, con i Francesi di Filippo di Montfort e del maresciallo di Rirepoix in prima linea. Di rinalzo Francesi, Provenzali e Romani di Guy de Montfort e Guglielmo Estentart, agli ordini di re Carlo d'Angiò; seguiti da uomini delle Fiandra, del Brabante, dell'Hainaut e della Piccardìa, comandati dal conte di Fiandra. I Guelfi della Toscana, con Guido Guerra, costituivano un corpo a parte.[2]
La descrizione della battaglia, lasciataci da Ugo de Baussay, così è riportata dal Leonard: "Lo scontro cominciò con un lancio di frecce saracine contro i fanti francesi che, come di consueto, coprivano momentaneamente la cavalleria. Questa intervenne a disperdere i Saraceni e quindi s'iniziò l'urto fra il grosso dei due eserciti. Dapprincipio i Tedeschi fecero indietreggiare gli avversari, ma questi contrattacca-rono con tale furia -incitati da Carlo che si era lanciato nella mischia gettandovi insieme tutte le sue forze- che la prima linea di Manfredi ne venne decimata; la seconda tentò di sostenere l'urto ma non vi riuscì. La riserva si diede alla fuga. Manfredi, che seguiva l'azione da un colle, respinse il consiglio di fuggire anche lui e, gettatosi nel folto della mischia, vi trovò la morte insieme al suo amico Tebaldo Annibaldi, rampollo di una grande famiglia romana, che non aveva voluto abbandonarlo".[3]
Un documento dell'Archivio Segreto Vaticano[4] riporta la relazione fatta, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, da Carlo I a Papa Clemente IV: "Sicque factum est itaque in ipso campo tanta strages, quod celant campum oculis superiacentia corpora occisorum ... Nec tamen omnes fugientes fuge remedium salvos fecit, quia maior pars fugientium in gladio nostrorum ... eo copiosus ceciderit".
Furono fatti, però, anche molti prigionieri, tra i quali Giordano e Bartolomeo Lancia, parenti siciliani di Manfredi; Pieraccino degli Uberti, l'abominevole capo dei ghibellini di Firenze: "perfidissimus Gibelline factionis auctor".[5]
Unico dubbio la morte di re Manfredi: "... de Manfredo autem, utrum ceciderit in conflictu, vel captus fuerit, aut evaserit, certum adhuc aliquid non habetur".[6]
Il primo marzo successivo, in una seconda missiva,[7] re Carlo annunzia al pontefice la morte di Manfredi e la sua sepoltura "... non tamen ecclesiastice" poichè scomunicato, ma "... cum quadam honorificentia".[8]
Nota è a questo punto la colta polemica circa la sepoltura e successiva esumazione di re Manfredi.

Difatti la tradizione (Villani,[9] Dante[10]) vuole che lo Svevo sia stato seppellito in un primo tempo presso il ponte della Morella (Benevento) e successivamente presso il fiume Liri, ai confini tra Regno di Napoli e Stato Pontificio.
Se ciò avvenne, certamente va collocato successiva-mente al maggio 1266, poiché in tale data il Papa poteva affermare che "... il nostro diletto figlio Carlo, re di Sicilia, possiede pacificamente tutto il regno, avendo in suo potere il cadavere putrido di quell'uomo pestilenziale (re Manfredi), sua moglie, i suoi figli e il suo tesoro".[11]
Ciò che re Carlo non potè impedire fu il saccheggio di Benevento, non escluse le chiese, che gli valse il biasimo del Pontefice.[12]
Tra i comandanti angioini vi era anche il milite Nicola de Rogatis, di Castellammare, che dopo la battaglia si era, insieme con i suoi uomini, abbandonato al saccheggio della Basilica di S. Sofia, impadronendosi, tra l'altro, di "os unum parvum nec non duos dentis"[13] della reliquia di S. Paola Romana.
I de Rogatis, giunti a Castellammare da Padova in seguito alla persecuzione di Ezzellino III da Romano (1194-1259), vicario imperiale e genero di Federico II di Svevia, si erano di poi schierati a favore di Carlo I d'Angiò. La famiglia, in quest'epoca, era rappresentata da Giovanni de Rogatis, dalla moglie Camilla de Camposampiero e dai figli Nicola, Leone e Luigi, detto Luisio de Rochè.
Camilla de Camposampiero apparteneva ad una delle pid antiche famiglie patavine, ivi giunta nel 1013 al seguito dell'Imperatore Enrico II, dal quale aveva avuto in feudo il Castello di Camposampiero, che diede, così, origine alla casa dei Tisoni.[14]
Si era stabilita in Castellammare,[15] nei pressi del Real Palazzo di Quisisana, nel luogo detto ab antiquo S. Lorenzo e, successivamente, Casa de Rogatis,[16] "et proprie in domo quae est prope ubi habitavit dictus dominus Rex”.[17]
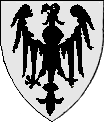
Questo saccheggio, ad opera del giovane Nicola, forse pesava sulla coscienza[18] dell'anziano Giovanni de Rogatis, consigliere regio, tanto che nel mese di maggio del 1268, "... infirmus in lecto", e temendo "... suae mortis ex hac infirmitate", per atto del notaio Guglielmo Iacta, stabiese, dona al Monastero di S. Sofia di Benevento, rappresentato dal "... Venerabili Viro Dopno Nicolai Abbati", "... brachium et dentem S. Jacobi Apostoli, et os parvum S. Petri Apostoli et aliud S. Justine"[19] che aveva portato da Padova. Obbliga, inoltre, il proprio figlio Nicola e, in mancanza, la moglie e tutti gli altri figli di fondare nella Cattedrale stabiese una Cappella sotto il titolo di S. Nicola. Dona, infine, trecentocinque once d'oro a S. Sofia per eventuali altri danni arrecati alla chiesa.
Due anni dopo, nel 1270, la Cappella fu fondata ed è, oggi, la prima, a destra, entrando in Cattedrale.[20]
In tale Cappella campeggia, recentemente restaurato, un pregevole dipinto, su tela, di S. Nicola di Mira. L'autore è ignoto, anche se non lo sono il committente ed il periodo.
Difatti da un documento del 1704[21] si evince che fu commissionato in Napoli, nella seconda metà del seicento, da Francesco de Rogatis, castellano di Castell'a mare.[22]
Tale Cappella, che -come documentato nel 1704- si trovava "... a mano dritta nello ingresso di detta Chiesa", portava due lapidi marmoree, ora non più esistenti e, quindi, ancora inedite. "Nel lato dritto e propriamente nel muro di detta cappella in cornu evangelii è posta l'infrascritta iscrittione incisa in marmo bianco antico le di cui parole trascripte de verbo ad verbum sono le seguenti videlicet:
D.O.M
SACELLUM HOC DIVO NICOLAO SACHRUM
A NICOLAO QUONDAM DE ROGATA MILITE
CAROLO PRIMO ANDEGAVENSI
VERUM POTIENTE ERECTUM GENTILITIE EIUS
HAC POSTERI AD MELIOREM CULTUM
REFORMARI CURAVERUNT
IN QUO FRANGISCUS DE ROGATIS LEGUM PERITUS
VINCENTIO FRATRI SUO
HUIUS TEMPLI TESAURARIO
MONUMENTUM HOC ARMORIS PROPRIUS
POSUIT ANNO DOMINI M.D.C.X.I."[23]
"Nel mezzo della medesima cappella in terra vi è una lapide sepolcrale seu un coverchio di sepoltura[24] in cui vi è scolpita l'arma seu impresa della detta famiglia de Rogati in marmo bianco con la sottoscritta inscrittione, cioè a dire:
DOMINUS CESAR DE ROGATIS
TEGUMENTUM HOC MARMOREUM
PRO SEPULTURA FAMILIAE DE ROGATIS
CONSTRUENDUM MANDAVIT IN TESTAMENTO 1575 ... [25]
FRANCISCUS DE ROGATIS UID
FILIUS E (sic) HAERES IUSSU FECIT”[26]
La famiglia fu molto devota ai sovrani angioini, tanto che Leone de Rogatis nel 1269 e 1270 è nell'elenco dei "mutuatores" di danaro a Carlo d'Angiò, privilegio riservato solo a pochi;[27] e nel 1284 Stefano, nipote di Giovanni, è milite.
Con la fine della dinastia angioina inizia il lento declino dei de Rogatis, declino vieppiù accentuato nel periodo aragonese. Difatti questa illustre famiglia sarà costretta dal secolo XVI al XVIII a ricorrere spesso alle aule giudiziarie per il riconoscimento dei propri diritti nobiliari, che a tal epoca erano reputati non tanto "fons honorum" bensì fonte di potere.
A P P E N D I C E I
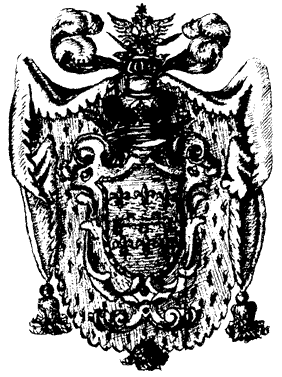
Sanctissimo in Christo patri et dom(ino) suo Clementi, divina provi- dentia sacrosanctae Romane Ecclesie summo Pontifici, Karolus D(ei) g(gratia) Rex Sicilie etc. cum omni reverentia et honore, devota pedum oscula beatorum. Multum meis reputans successibus adiici, si Romana Mater Ecclesia de felicibus filiis processibus, in quibus sua causa provehitur, certa fuit. Ecce significo vobis ad gaudium quod postquam Manfredus, publicus hostis, victus apud Sanctum Germano, a Capua quoque, ubi se iactabat velle resistere, confusus abcessit. Accepi quod idem hostis, cum suarum reliquiis virium, que de Sancto Germano per fugam evaserant, profugus per Terram Laboris, se transtulit Beneventum. Ego autem, meas continuando dietas, per Aliphanos et Telesinos campos contra ipsum hostes duxi ... Sicque factum est quod die Veneris XXVI mensis februarii ... viarum et passuum difficultatibus ... superatis, ad quendam montem perveni, unde subiectus et admodum patens campus ordinatas iam hostium acies ostendebat. Propter quod ego, licet equos commilitonum meorum pro malitia et magnitudine itineris cognoscerem plurimum fatigatos, ... instructis tamen meis ... copiis, ex adverso ad pugnam processi. Et quamvis per magnam horam fuerit utrumque decertatum, cedentibus tamen, divine potentie non meis viribus, duabus prioribus hostium aciebus, omnes alie, cum non confiderent aggredientium impetum sustinere, se fuge remedio commisere. Facta est itaque in ipso campo tanta strages, quod celant campum oculis superiacentia corpora occisorum. Nec tamen omnes fugientes fuge remedium salvos fecit, quia maior pars fugientium in gladio nostrorum ... eo copiosus ceciderit, quo dispersius fugiendo nec unus tuebatur alterum, nec eis loca ad que confugerent apparebant. Magnum ergo numerum captivorum ad carcerem nostrum huiusmodi bellicus eventus adduxit, inter quos Iordanus et Bartholomeus dictus Simplex, qui nomen sibi Comitum hactenus usurparunt, eorum fratres, nec non Pierasinus de Florentia, perfidissimus Gibelline factionis auctor, in vinculis detinentur. De his autem, qui de prioribus partis adverse in prelio corruerunt, certam non habens notitiam, nichil vobis exprimere potui propter festinam presentium missionem, licet Galvanus et Herrigectus, dicti Comites, michi a pluribus asserantur in eodem prelio corruisse. De Manfredo autem, utrum ceciderit in conflictu, vel captus fuerit, aut evaserit, certum adhuc aliquid non habetur; destrarius autem, cui insedisse dicitur et quem habemus, casus affert non modicum argumentum. Hec igitur ... Beatitudini vestre denuntio, ut omnipotenti Deo ... devotas pro tanto triunpho gratias referatis. Certam spem et fiduciam teneatis quod, eradicatis de Regno Sicilie scandalis ..., illud ad antiquam et consuetam devotionem Ecclesie Romane plene reducam ...
Datum Beneventi, XXVI februarii, ind(ictione) IX, R(egnorum) n(ostrorum) a(nno) I.
FONTI:
Archivio Vaticano
Ed. in: I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti, etc., Napoli 1963, II ed., vol. I, pp. 17-18.
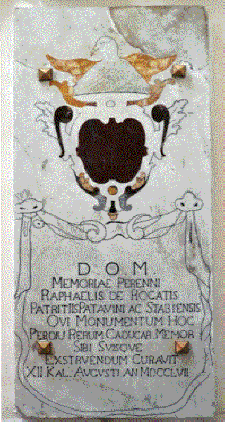
A P P E N D I C E II
Sanctiss(imo) in Chr(isto) patri et dom(ino) Clementi etc. Triunphum michi concessum celitus de Manfredo hoste publico apud Beneventum Sanctitati vestre nuper memini meis licteris intimasse. Verumque invalescente de casu eiusdem hostis in conflictu, investigare feci in campo corpora mortuorum, pro eo etiam quod nullus memor ipsum Manfridum predicabat fuge auxilio ad locum aliquem pervenisse. Contigit quod die dominica XXVII mensis februarii corpus eius inventus est nudum inter cadavera peremptorum. Ne igitur error sibi locum in tanto negotio vendicaret, Richardo Comiti Casertano ... nec non Iordano et Bartholomeo dictis Comitibus et fratribus eorum aliisque etiam, qui eum familiariter ... tractaverunt, dum vivebat, ostendi feci; qui recognoscentes ipsum, predictum esse olim Manfridum preter omnem dubium affirmabant. Ego itaque, naturali pietate inductus, corpus ipsum cum quadam honorificentia sepulture, non tamen ecclesiastice, tradi feci.
Datum in castro apud Beneventum, primo mensis martii, R(egnorum) n(ostrorum) a(nno) I.
FONTI:
Archivio Vaticano.
Ed. in: I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti, etc., Napoli 1963, II ed., vol. I, p. 18.
APPENDICE III
[Fundatio Cappellaniae]
Copia
In Nomine Domini Jesu Christi. Anno Incarnationis Dominicae 1268. Regnante inclito Domino nostro Carolo Dei gratia Hierusalem et Siciliae Rege Ducatus Apuliae et Principatus Capuae Provinciae et Folfarcheriae (sic) et Pedimontis Comite, Regni vero eius anno III Mense Madii Indictione duodecima.
Nos Rogerius de Puteo Castrimaris de Stabia Iudex, Gulielmus Iacta publicus eiusdem Civitatis Notarius, Simeon de Longa, Tomasius Conus, Trasemune Certa testes ad hoc specialiter vocati et rogati; Per hoc scriptum notum facimus, quod Magnificus Dominus Ioannes de Rogata miles vir praeclarus de Civitate Paduae habitator Castri maris de Stabia, et Consiliarius praedicti Domini Regis, apud dictam Civitatem Castrimaris in loco ubi dicitur S. Laurentius, et proprie in sua domo, quae est prope ubi habitavit dictus Dominus Rex, infirmus in lecto, habens bonam loquelam, et memoriam, coram nobis sponte asserit, et declarat habere et tenere apud se os unum parvum nec non duos dentis S. Paulae Romanae, quod totum Nicolaus miles suus filius tulit secum de Sacrario Monasterij S. Sophiae Beneventi in ultimo bello pro particulari devotione ad istam Sanctam suae propriae familiae, et generis de filiis Rogati. Verum intendens ad censuras fulminatas, et ad quaerelas praedicti Monasterij pro nonnullis reliquijs sublatis de suo Sacrario, et pro alijs damnis illi proventis in bello timens casum fragilitatis humanae, et multo plus iustitiam Omnipotentis Dei, ut cum bona conscientia, et sine censuris ex isto seculo decedat, praesenti scripto notum facit, et declarat hoc ablatum Venerabili Viro Dopno Nicolai Abbati praesenti praedicti Monasterij S. Sophiae, et illi ad partem Monasterij pro talibus reliquijs memoratae suae Sanctae, quas habere desiderat pro praetioso tesauro suae stirpis obtulit et dat brachium, et dentem S. Jacobi Apostoli, et os parvum S. Petri Apostoli, et aliud S. Justinae, quae omnia secum tulit (›Hfol. 1r›@) de Padua in persecutione Ecelini: Quod si praedicto Venerabili Abbati, et Monasterio non placebit commutatio, obligat ipsum suum filium ad restituendum totum suum erat. Et pro damnis factis cuidam petiae terrae unius tenimenti Monasterij, et etiam uni Cappellae S. Nicolai de praedicto Monasterio a militibus dicti sui filij Nicolai eorum Capitanei ad plenam satisfactionem, et ad redemptionem peccatorum suorum sicuti illi congruum esse videtur bona sua voluntate obtulit, et dat praedicto Monasterio, et ad partem illius preascripto Venerabili Abbati Nicolao uncias auri triginta, et quinque pro una vice; et etiam obligat ipsum suum filium Nicolaum ad fundandam in hac Civitate, sive in Padua si ad illam redibit Cappellam unam, seu Ecclesiam parvam cum beneficio dotatam ad honorem talis S. Nicolai offensi sui particularis patroni ex quando in Barium venit: et commendat Camillae de Camposanpero suae uxori, et Leoni suo filio nunc presentes, et etiam filio Luisio militi si de Gallia redibit, ut in eventum suae mortis ex hac infirmitate in continenti iuzta continentiam faciant observare. Quod si tamen ipse Nicolaus non fecerit intra duos annos, aut intricare tentaverit obligat in bonis omnibus etiam domus Rogatae et aliorum haeredorum praedictorum Nicolaum et suos filios, et haeredes omnes ad dandas uncias auri sex pro uno quoque anno omni futuro tempore Sacrario S. Sophiae.
Quod scripsi Ego praescriptus Gulielmus publicus Castrimaris de Stabia Notarius quia praedictis interfui eo solito meo signo signavi.
Actum in dicta Castromaris de Stabia feliciter.
Ego qui supra Rogerius de Puteo Judex.
FONTI:
ASD, proc. di beneficio, processo de Rogatis, fol. 54r.
A P P E N D I C E IV

Si fa fede da me sottoscritto Abbate di S.ta Maria a Cappella a qualsivoglia spettará, o potrá spettare vedere la presente, sive in judicio, sive extram et cum juramento quatenus opus sit, come stiè lungo tempo in mia casa fuora Porta di Chiaia un quadro, seu cona grande di S. Nicolô di Mira di mano ....................... (sic) fatta a spesa del Sig. quondam Francesco de Rogati castellano Regio, della Cittá di Castell'a mare; di Gio: Battista Residente dell'Serenissimo di Neoburgo, et Inviato al Papa dalla Maestá del Re di Polonia, di Giuseppe e Carlo fratelli utriunque congionti e che poi detta cona ut supra fu da Geronima de Rogati mia madrigna, sorella di detti fratelli, e moglie di Carlo Pandone barone di Forlì mio padre, assieme con suo marito fatta condurre seco in Castell'a mare per porsi nella Cappella di S. Nicolô de Rogati, eretta nel Vescovado di Castell'a mare, per cui era stata fatta dipingere, come infatti fu collocata, posseduta di presente da' figli del suddetto quondam Sig. Giuseppe de Rogati, Sig. D. Cesare, Padre Tomaso della Compagnia di Giesú, Sig. D. Goffredo de Rogati, e loro sorelle Sig.a D. Laura e suor Maria Giesumina monica professa nel Moastero di essa Cittá, Patritii della medesima, come in fatti vi si pose, et hora vi stá, costando questo a me de causa scientiae per essere cosa appartenente a mia Casa, ho fatta la presente firmata di mia propria mano, e sigillata col mio proprio sigillo.
Napoli li 15 febbraio 1704.
D. Angelo Pandone abbate di S.Maria a Cappella eccetto come di sopra.
FONTI:
ASD, proc. di beneficio, processo de Rogatis, fol. 58r.